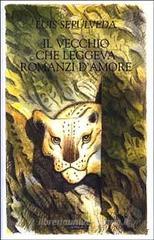LO SPAZIO
Sono molti e diversi i luoghi in cui sono ambientate le
novelle del Decameron, vengono infatti descritti palazzi, residenze di
campagna, città e corti.
Nella novella di
Andreuccio da Perugia, ad esempio, vediamo l’affollata fiera di cavalli nella
città di Napoli, gli stretti vicoli, le fogne ad aria aperta nella parte più
malfamata della città, il porto , la chiesa maggiore frequentata più da ladri
di tombe che da fedeli. La novella si
ambienta in una Napoli pericolosa e al contempo piena di vita, in un’epoca in
cui la città era ancora un importante centro culturale.
In un ambiente non borghese, bensì nobiliare, si svolge la
novella di Federico degli Alberighi. La sua storia è ambientata inizialmente
nella città di Firenze, dove si tengono ricevimenti, tornei e duelli, quindi,
dal momento che Federico ha dilapidato le sue ricchezze ed è costretto a
ritirarsi nel suo podere in campagna, qui si svolge la seconda metà della
novella. La campagna viene descritta sia come un luogo di svago per i ricchi,
sia come una misera fonte di sostentamento per i poveri. Qui Federico si occupa
del suo orto, e sopravvive procurandosi il cibo con la caccia. Si può notare
quindi l’associazione: città-ricchezza e campagna-povertà.
Un’altra novella in cui vediamo due ambientazioni differenti
è quella di Nastagio degli Onesti, che inizia nella città di Ravenna, in
ambiente nobiliare, e si conclude poi in una pineta vicino a Classe, in un
luogo aperto. Se la città è un luogo di
cultura, dove vivono i nobili e dove si sviluppa il commercio, la campagna è il
luogo dove vivono gli ignoranti e lavorano i poveri, nonostante sia qui che si
ritirano i nobili nelle stagioni più calde, per trovare sollievo nelle loro
residenze fuori città. Se alcune novelle
sono ambientate in città mercantili , come Napoli, Firenze o Pavia, altre sono
ambientate in corti e palazzi, come la novella di Agilulfo il re barbiere : la
storia si svolge alla corte di Pavia, nel palazzo pieno di servitori vivono il
re e la regina, in un ambiente ancora feudale.
.
VIRTU’ E FORTUNA
La concezione di virtù di Boccaccio è molto moderna per i
suoi tempi, quasi rinascimentale: la virtù è intesa come l’abilità che si mette
in campo per contrastare il caso. Per Boccaccio questa abilità è data
dall’intelligenza, l’ingegno che ci permette di dominare la realtà e dominare
la Fortuna. Il concetto boccacciano di fortuna è indubbiamente laico, in quanto
la Fortuna, che può essere dominata o dominare la nostra vita, non è intesa
come volere divino, bensì come “caso” che condiziona, volenti o nolenti, le
vicende umane e il flusso degli eventi. La Fortuna è quindi una forza autonoma,
che sostituisce la divina Provvidenza. Ne consegue che per Boccaccio la virtù
consista nel saper governare la Fortuna, cogliendo le occasioni propizie e
reagendo in modo positivo ai colpi della sorte avversa mediante l’arguzia, la
furbizia, l’uso intelligente e abile della parola.
Nella novella di Frate Cipolla, ad esempio, il frate riesce
a dominare la Fortuna, grazie all’abile uso della parola. Così anche Ser
Ciappelletto, nella prima novella della prima giornata, riesce a volgere la
situazione a proprio favore grazie al suo ingegno e alla sua abilità nel
parlare, e riesce a dominare la realtà, fornendoci un chiaro esempio di virtù boccacciana: saper
governare la Fortuna, senza preoccuparsi della correttezza morale del fine o
del mezzo. Ser Ciappelletto riesce a dominare il destino ingannando persino il
rappresentante di Dio, per poi essere adorato come modello di santità
cristiana, e seppellito in una cattedrale.
IL DENARO
Nelle novelle di Boccaccio, il denaro ha spesso un ruolo
chiave, poichè è causa di inganni e sventure. Boccaccio critica sia gli avidi,
come Landolfo Rufolo, sia i dissipatori, come Nastagio degli Onesti. Infatti,
sebbene Boccaccio ritenga che il denaro sia importante nella vita, dal momento
che ne rimase a lungo privo, non approva gli avidi e gli scialacquatori,
promuovendo invece una gestione oculata del denaro. Boccaccio presenta i nobili
come dissipatori, ed i mercanti come avidi accumulatori. Per il Boccaccio, la
virtù borghese consiste nel saper amministrare i beni e il denaro, cosa che non
sempre i nobili sanno fare. Boccaccio non biasima chi, con l’inganno, accumula
denaro, come Frate Cipolla o Madama Fiordaliso, anzi sottolinea che non è
sbagliato trarre profitto da ogni situazione, anche mettendo da parte i valori
morali.
CORTESIA e RICCHEZZA
Per Boccaccio, la cortesia non è più una caratteristica
propria dei nobili che si acquisisce per nascita, bensì una nobiltà dell’animo
che si ottiene tra alle proprie qualità personali. La cortesia è la virtù che
rende l’uomo generoso della sua ricchezza e magnanimo verso chi lo merita. Per
Boccaccio la cortesia è uno dei valori sui quali rifondare la società
fiorentina; tuttavia, egli parla di una cortesia borghese, conciliata con
l’abilità di amministrare il denaro.
Infatti, Boccaccio
intravede nella cortesia medievale, come quella di Federico degli Alberighi, un
pericolo per le ricchezze che vengono rapidamente dilapidate.
Secondo Boccaccio è
perciò necessario conciliare la mentalità borghese con quella feudale: la
cortesia, la magnanimità e le nobili qualità devono essere unite alla virtù
borghese di saper amministrare i beni e il denaro. Per la mentalità mercantile,
la massima virtù consiste nell’accumulare denaro e non farsi travolgere dai
colpi della sorte, nell’indipendenza e nella laboriosità. Per la mentalità
feudale ,invece, la virtù consiste nella
magnanimità, nelle prodezze guerriere, nel disprezzo del lavoro, del denaro e
del risparmio. Il Boccaccio suggerisce quindi di unire gli aspetti migliori
delle due concezioni di virtù: magnanimità e buona amministrazione del denaro.
LA PAROLA
In Boccaccio la parola ha un’importanza fondamentale, è il
mezzo con cui si può esprimere la propria intelligenza, lo strumento che
permette di volgere sfortunate circostanze a proprio favore. Con l’abilità oratoria, tanto celebrata da
Boccaccio in tutto il Decamerone, si
può governare il caso e dimostrare la propria arguzia, come nel caso di Guido
Cavalcanti o del cuoco Chichibio. Nella novella, il cuoco riesce a trarsi
d’impaccio con il suo padrone, grazie ad una risposta arguta, evitando quindi
una severa punizione. Guido Cavalcanti invece, sentendosi accerchiato da Betto
Brunelleschi ed i suoi amici, li lascia di stucco con una sottile battuta,
pronunciata la quale esce di scena.
La parola dimostra le
effettive capacità dei personaggi, la loro intelligenza e il loro spirito, e,
come nella novella di Cisti il Fornaio, è in grado di porre allo stesso livello
due individui di diversa estrazione sociale.
RISPETTO E DISPREZZO
Secondo Boccaccio, sono degni di rispetto tutti coloro che,
grazie alla loro intelligenza, riescono ad approfittare di ogni situazione e
dominare la Fortuna. Indipendentemente dalla correttezza del loro fine ultimo,
Boccaccio apprezza nei suoi personaggi la prontezza di spirito e l’ingegno.
Persino un truffatore assassino e bugiardo come Ser Ciappelletto viene apprezzato
dall’autore, in quanto riesce a risolvere ogni problema grazie al suo ingegno,
sebbene in modo del tutto amorale.
Boccaccio disprezza invece gli ignoranti, i pecoroni, gli
stolti, i superstiziosi e i creduloni, tutti coloro, insomma, che si lasciano
ingannare o dominare dagli eventi, che restano inevitabilmente vittime di
raggiri a causa della loro stupidità o ingenuità. L’autore disprezza inoltre il
clero, i sacerdoti della curia romana, che sono il simbolo della corruzione e
del degrado umano.